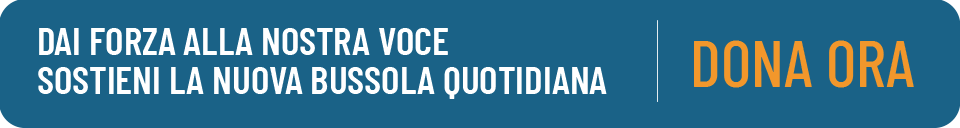Non solo Garlasco, quanto costa riaprire i processi
Ascolta la versione audio dell'articolo
Ogni caso riaperto grava su un un sistema giudiziario già in affanno. Ma se il clamore mediatico supera le reali novità investigative a pagarne il prezzo sono tutti i cittadini in attesa di un giudizio che tarda ad arrivare.

Riaprire un processo penale chiuso da anni è un’operazione che, al di là della legittimità giuridica e del valore morale nel caso in cui porti a una revisione fondata, solleva interrogativi profondi e spesso sottovalutati, soprattutto sotto il profilo economico e sociale. I costi per le casse dello Stato e, quindi, per i cittadini, sono infatti enormi. Ogni indagine riaperta implica la mobilitazione di un apparato complesso, fatto di magistrati, forze dell’ordine, periti, tecnici, laboratori e servizi amministrativi, tutti impegnati a tempo pieno per settimane, mesi, e talvolta anni.
Ma il vero nodo critico risiede nel fatto che queste operazioni, spesso alimentate da nuovi clamori mediatici più che da reali novità investigative, finiscono per gravare su un sistema giudiziario già in affanno e, in molti casi, si concludono senza mutare l’esito del processo originario. In questi casi, la macchina della giustizia si mette in moto, produce spese, sottrae risorse e, alla fine, non restituisce nulla di più certo o giusto di quanto già stabilito.
Basta scorrere l’elenco dei casi celebri per capire quanto l’apparato giudiziario venga appesantito da queste riaperture. Dalla revisione del caso di Garlasco, che a quasi vent’anni dal delitto ha visto un impressionante dispiegamento di forze, fino ai casi di Serena Mollicone, Elisa Claps o Yara Gambirasio, ogni nuova pista, ogni nuovo indizio, ogni richiesta di incidente probatorio apre un capitolo che costa centinaia di migliaia, se non milioni, di euro.
Il solo prosciugamento di un torrente, come avvenuto nella recente indagine supplementare a Garlasco, richiede la partecipazione di Protezione civile, vigili del fuoco, polizia municipale e tecnici specializzati. Si tratta di operazioni che coinvolgono strumentazioni complesse, trasporti, trasferte, straordinari, che richiedono budget straordinari. E se, come accade nella maggior parte dei casi, tali operazioni non conducono a un ribaltamento della verità processuale, resta solo il peso di un costo spropositato a carico della collettività.
Sotto questo profilo, è importante sottolineare come i media svolgano un ruolo decisivo nel rianimare vecchi casi giudiziari. La spettacolarizzazione delle inchieste, spesso più vicina al linguaggio della fiction che a quello del diritto, contribuisce a creare una pressione emotiva e popolare che condiziona la percezione dell’opinione pubblica e alimenta aspettative che il diritto, con i suoi strumenti tecnici e rigorosi, difficilmente può soddisfare. Non è raro che si parli di “nuovi elementi” che, alla prova dei fatti, non costituiscono altro che reinterpretazioni di quanto già acquisito. Eppure, è proprio da questi clamori, da queste amplificazioni, che spesso nascono le spinte per chiedere la revisione di un caso. Si arriva così a mobilitare l’intero apparato investigativo e giudiziario non per fatti nuovi e dirompenti, ma per suggestioni che hanno trovato spazio nei talk show e nei servizi televisivi del prime time.
La legge, certo, consente la revisione dei processi. L’articolo 630 del codice di procedura penale è chiaro: se emergono nuove prove, è giusto che il condannato possa chiedere di rivalutare il caso. E nessuno nega che ci siano stati, in passato, errori giudiziari corretti proprio grazie a questa possibilità. Tuttavia, l’abuso di questo strumento, o il suo utilizzo sulla base di indizi fragili, non solo mina l’equilibrio della giustizia, ma rappresenta un danno economico reale. Non solo per via dei costi diretti delle indagini, ma anche per l’impatto che queste hanno sulla funzionalità complessiva del sistema: magistrati distolti da altri fascicoli, rinvii di processi in corso, rallentamenti a catena nelle cancellerie già sovraccariche. La lentezza della giustizia in Italia è una criticità strutturale, e ogni volta che un processo già chiuso viene riaperto senza solide basi, il prezzo lo pagano non solo le parti coinvolte, ma anche tutti quei cittadini in attesa di un giudizio che tarda ad arrivare.
È necessario, allora, interrogarsi con serietà su dove si trovi l’equilibrio tra il diritto alla giustizia e la sostenibilità del sistema giudiziario. L’etica del dubbio, che anima giustamente ogni sistema democratico, deve fare i conti con il principio della certezza del diritto. Ogni processo riaperto scava nella memoria di famiglie che magari hanno trovato un difficile equilibrio, risveglia sospetti, alimenta nuove sofferenze. Se alla fine del percorso il verdetto resta invariato, il dolore si moltiplica. E si affianca, a quello morale, quello economico. In certi casi, persino il risarcimento per ingiusta detenzione o errore giudiziario può comportare esborsi ingenti da parte dello Stato. Ma quando non c’è nessun errore da riparare, solo un’inchiesta che non ha prodotto frutti, allora si può parlare a ragione di spreco.
È giusto, allora, che il dibattito pubblico si interroghi su questi temi senza farsi travolgere dall’emotività. La riapertura dei processi non può diventare un atto di routine o la risposta automatica a ogni nuova interpretazione di vecchi fatti. Serve rigore, serve prudenza, serve una valutazione oggettiva dei benefici attesi rispetto ai costi generati. In un sistema che fatica a far fronte alla mole di cause civili e penali pendenti, ogni deviazione di risorse verso processi che raramente portano a un ribaltamento del giudizio finale rischia di compromettere il diritto alla giustizia di molti altri.
Non si tratta di negare il diritto alla verità, né di sminuire la possibilità di correggere errori bensì di restituire al processo penale la sua giusta dimensione: quella di uno strumento rigoroso e ponderato, non di un teatro per il dramma collettivo. Il rispetto per le vittime e per gli imputati, per i familiari e per la società tutta, passa anche attraverso la responsabilità con cui si decide di riaprire o meno una vicenda giudiziaria. Le istituzioni devono avere il coraggio di distinguere tra ciò che è necessario e ciò che è solo desiderato, tra ciò che è utile e ciò che è solo eccessivamente costoso. E se davvero una nuova prova emerge, allora sì, è giusto rimettere tutto in discussione. Ma non si può dimenticare che la giustizia, come ogni servizio pubblico, ha un prezzo. E quel prezzo lo pagano i cittadini.