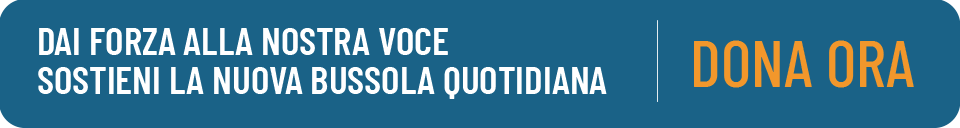L’autocomunione e il divieto della Chiesa antica
Fin dai primi secoli vigeva nella Chiesa il divieto per i fedeli di autocomunicarsi, eccezion fatta per le situazioni di persecuzione. L’attuale pratica della Comunione sulla mano, ben diversa da quella antica sul palmo, è una forma ibrida di ricezione e autocomunicazione. L’equivoco sul verbo, polisemico, λαμβάνω (lambáno).

Il moderno ritorno agli usi liturgici dell’antichità è contrassegnato da una selettività sospetta. Si è visto come (qui e qui), dell’antico rito che prevedeva la recezione dell’Eucaristia sul palmo, siano stati ignorati aspetti di grande importanza: l’assunzione della Sacra Ostia direttamente dal palmo, senza l’azione prensile delle dita della mano destra; i riti di abluzione antecedentemente alla ricezione della Comunione; l’utilizzo di un telo di lino, almeno da parte delle donne; l’atto di adorazione (e non di semplice “rispetto”) che deve precedere la ricezione dell’Eucaristia.
Una caratteristica universale della modalità delle antiche chiese di amministrare l’Eucaristia era il divieto assoluto che il fedele si autocomunicasse, eccezion fatta per le situazioni di persecuzione, quando i fedeli erano autorizzati a portare le sacre specie nelle proprie dimore e comunicarsi. Al di fuori di queste eccezioni, nessun fedele poteva prendere l’Eucaristia con le proprie mani, ma doveva riceverla dal ministro sacro.
Questa sonora proscrizione dovrebbe far pensare. Se si fa attenzione alle caratteristiche della Comunione sul palmo com’era probabilmente praticata, si può notare che, da parte del fedele, non esiste alcuna azione prensile. Egli, al contrario, riceve da parte del ministro la Comunione: sul palmo, per poi assumerla direttamente con la bocca. La nuova modalità prevede invece l’atto del prendere con le mani; è infatti prescritto che il fedele afferri l’Eucaristia ricevuta sulla mano sinistra con le dita della mano destra, finendo così di fatto per autocomunicarsi. Si potrà obiettare che rimane pur sempre la mediazione del ministro; ma, a ben vedere, a questa prima ricezione (dal ministro alla mano sinistra del fedele) segue l’azione del fedele che prende l’Eucaristia con le dita e si comunica. A onor del vero, dovremmo dunque, come minimo, parlare di una forma ibrida di ricezione e autocomunicazione. Pertanto, sotto questo aspetto, l’attuale modalità di accostarsi alla Comunione non è solamente nuova rispetto all’antica, ma appare persino contraria alle antiche norme che proibivano al fedele di comunicarsi da solo, ossia di prendere la particola consacrata per portarsela alla bocca.
Ora, qui ci si inoltra su un altro terreno fecondo di equivoci. I difensori della Comunione sulla mano tengono a precisare che questa modalità sarebbe conforme al comando di Cristo «prendete e mangiate». Se però il comando di Cristo fosse effettivamente quello di “prendere, afferrare”, allora bisognerebbe domandarsi come mai anche nei primi tempi della Chiesa – ben prima dei “tempi bui” evocati da mons. Bruno Forte – fosse proibito prendere la Comunione da sé.
Se il comando del Signore – prima ipotesi – fosse realmente quello che ciascun fedele debba prendere l’Eucaristia, non si capisce come mai la Chiesa abbia sempre compreso la mediazione del ministro ordinato come ordinariamente imprescindibile. Il che significa che il fedele non può prendere da sé il Pane consacrato, ma deve invece riceverlo dalle mani del ministro.
Se invece – seconda ipotesi – il Signore non avesse comandato di prendere l’Eucaristia, ma di riceverla, allora bisognerebbe chiedersi come mai il nuovo rito della Comunione sulla mano preveda effettivamente di prenderla dopo averla ricevuta.
Ma qual è effettivamente il comando di Cristo? Il “colpevole” del fraintendimento è il verbo λαμβάνω (lambáno), che offre una notevole polisemia, dal violento agguantare e predare, fino al più mite accogliere, ricevere. Sarebbe sufficiente questa precisazione per respingere l’affermazione che il verbo lambáno significhi inequivocabilmente il comando che l’Eucaristia debba essere presa con le mani.
Il canonico Grégoire de Guillebon (cf. La Communion dans la main aux temps apostolique, in Bref examen critique de la Communion dans la main, Versaille, 2021) offre una soluzione soddisfacente, che tiene conto di tre elementi: il tempo verbale utilizzato nei Vangeli, gli effetti di questo ordine, la traduzione latina.
Il tempo verbale è infatti l’aoristo, che viene impiegato per suggerire un valore temporale indeterminato, al di là del preciso contesto. Questa indeterminazione è fondamentale, perché permette di comprendere che ciò che viene comandato è di compiere l’offerta del pane e del vino e la loro consumazione come un rituale perenne, che parte dalla Cena del Signore, ma la oltrepassa nello spazio e nel tempo. E infatti, l’effetto di questo comando del Signore non è “solamente” l’istituzione dell’Eucaristia, ma anche l’istituzione del Sacerdozio. Non si deve dimenticare che il Signore dà pure il comando: «fate questo in memoria di me». Quel «prendete e mangiate» non indica pertanto la modalità di ricevere l’Eucaristia, ma il comando che il Signore dà agli Apostoli di fare quello che Lui sta facendo come memoriale perenne, istituendo così il Sacerdozio. I sacerdoti di ogni tempo prenderanno il Corpo e il Sangue del Signore, lo offriranno e lo consumeranno (mangiate, bevete), compiendo così il sacrificio della Nuova ed Eterna Alleanza. Dunque, i due primi aspetti – tempo verbale ed effetti del comando – mostrano che quell’ordine del Signore non riguardava la modalità di ricevere l’Eucaristia da parte degli Apostoli, modello dei futuri fedeli, ma l’essenza del rito del nuovo memoriale: i sacerdoti della Nuova Alleanza avrebbero dovuto compiere quel che vedevano fare dal Maestro, prendere e mangiare il suo Corpo, prendere il calice e bere il suo Sangue.
Riguardo al terzo aspetto, la traduzione latina presente nell’antichissimo Canone romano utilizza il verbo accípere, che, privato della specificazione ex manibus, non può certo avere il significato di prendere con le mani, bensì quello di ricevere. D’altra parte, paralleli nel Nuovo Testamento che utilizzano i verbi lambáno (in greco) e accípere (in latino) non possono che avere il significato di ricevere. In Gv 20, 22, il Signore dona lo Spirito Santo con questo comando: «Ricevete (lábete, accípite) lo Spirito Santo»; e non vi è dubbio che il significato non possa essere quello di prendere, tanto meno con le mani. Nel Prologo dello stesso Vangelo (1, 11), a quanti hanno accolto (élabon, recepérunt) il Verbo, Dio ha dato il potere di diventare figli di Dio; e anche in questo caso è evidente che non si tratta di prendere, ma accogliere, ricevere.
Si comprende dunque come sia del tutto fuorviante interpretare il comando del Signore come se fosse l’indicazione che i fedeli avrebbero dovuto comunicarsi prendendo il pane consacrato con le mani.
La Passione del Signore (V parte) – Il testo del video
La liberazione dal peccato e quella dal demonio: i primi effetti della Passione del Signore. In che senso essa ha operato la remissione dei peccati, anche futuri? E come il rimedio della Passione si applica ai singoli? Le risposte di san Tommaso.
La Comunione sulla mano e la visione distorta della Tradizione
La Chiesa, specie in ambito liturgico, ha avuto modo di mettere in guardia da due visioni distorte della Tradizione, entrambe componenti del “progressismo”: l’archeologismo e la smania di cambiare. La Comunione sulla mano è figlia proprio di una deviazione archeologista. Spieghiamo perché.
Comunione sulla mano e sulla lingua, una ricostruzione storica
In base alle fonti antiche, più che sulle mani si dovrebbe parlare di Comunione sul palmo. Le modalità non erano come quelle attuali, perché i Padri si preoccupavano della riverenza all’Eucaristia. E questa cura ha portato, come logico sviluppo, alla Comunione direttamente sulla lingua.
Negare la Comunione sulla lingua è un abuso giuridico
Il divieto di mons. Forte di dare l’Eucaristia sulla lingua non è giuridicamente vincolante perché è contrario alle leggi superiori della Chiesa, dalla Memoriale Domini alla Redemptionis Sacramentum. È perciò il vescovo di Chieti a porsi in disobbedienza. Consigli per i fedeli.
"Chieti" e non ti sarà dato: Forte nega la comunione in bocca
Nell'arcidiocesi abruzzese è obbligatorio ricevere l'Eucaristia sulle mani. L'arcivescovo si scaglia contro l'uso tradizionale e ammanta di obbedienza la pretesa di imporre la sua personale visione, forzando le norme e anche la lingua greca.